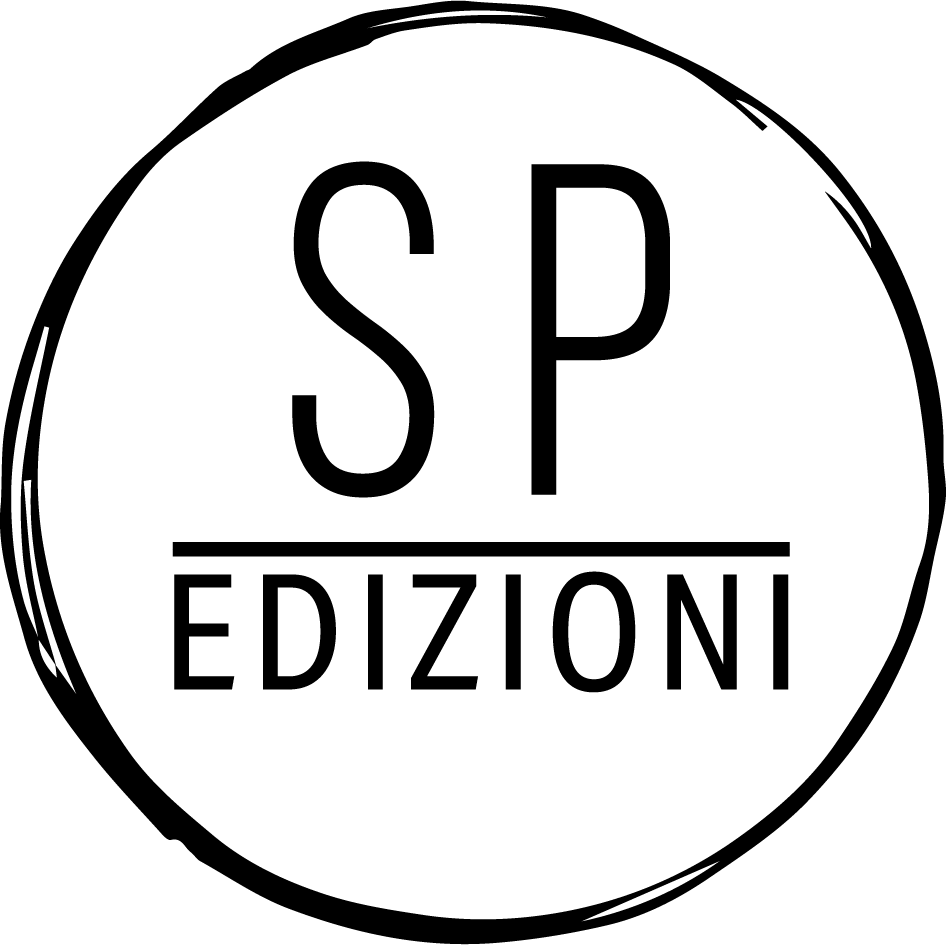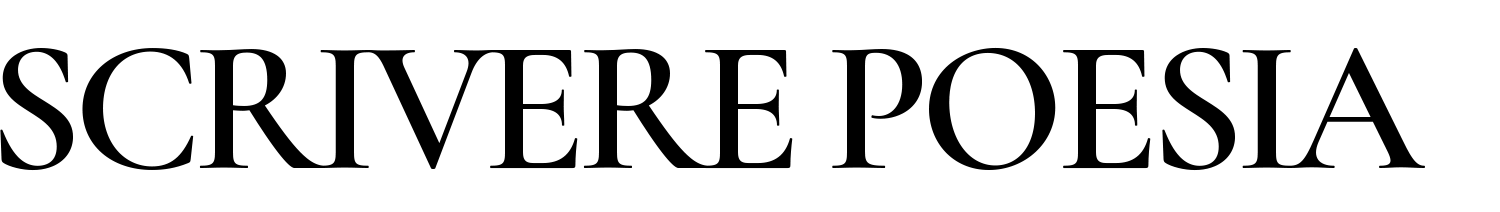Roberto Saviano definiva Arminio, in un articolo di Repubblica, come uno dei più grandi poeti di questo paese.
Un’affermazione che lascia perplessi: basti pensare alle voci femminili emerse e affermate negli ultimi anni, e si possono fare molti esempi (Antonella Anedda e Isabella Leardini, per dirne due). Di sicuro Arminio è fra i più amati e venduti in Italia e importanti editori lo propongono in belle edizioni. Leggendo piacevolmente questo libro, ho pensato che Arminio tutto dicesse e niente, eppure affabulava e bene.
Perché sentire Arminio così vicino, immaginarlo e immaginarsi in un paese lontano e fuori dal tempo, sentire la terra ch’egli decanta? Perché dovremmo, insomma, cedere la strada agli alberi, ma senza troppo pensarci?
Arminio è come un musicista con l’innato senso della melodia; non ha orecchio assoluto ma un buon orecchio, certo, ed ecco: quando poggia le mani su una tastiera, sa trovare la melodia – quella successione di note che di pancia piace e soddisfa, pur non facendoci mai conoscere dissonanze e trasfigurazioni. Insomma la melodia è giusta, esattamente quello che vogliamo udire. E per di più vaticinato da Saviano. Che dire? Solite cose, purtroppo, che è bello ciò che piace, e soprattutto se piace a tanti allora diventa oggettivamente bello. Ma l’oggettivazione di pancia non esiste né sussiste una poesia criteriata. Forse esiste ancora una poesia che sfiora un limite esistenziale assoluto con versi vicino al silenzio. Esattamente come la musica trascritta su pentagramma: nei suoi tratti fondamentali essa è interpretabile, certo, ma sfuggente, poiché se tutto suona, essa stessa finisce. E questo limite rappresenta l’amara meravigliosa realtà, che ad Arminio sfugge. Il titolo è forse la parte più bella del suo libro.